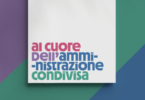Costituzione: un’arma contro la crisi
Il momento che stiamo vivendo non abbonda di certezze. Questo è sicuro. La frammentazione del sistema politico, i cedimenti di quello dei partiti, la paralisi di quello economico, indicano che la strada è tutta in salita per il nostro Paese, e la sua democrazia rappresentativa.
Ma è proprio nei momenti critici che serve tornare alle origini. Riscoprire le radici comuni, che magari consideriamo fin troppo ovvie, banali, e approfondire quel piccolo nucleo di regole su cui davvero siamo tutti d’accordo. Ecco quindi che la ricetta, dura o meno da mettere in pratica, è fare il possibile per ridare vita a queste regole. Capendo il contesto in cui ci troviamo e aggredirlo con decisioni giuste e condivise.
Da sempre Labsus si fa portatore di una rivoluzione. Una rivoluzione che non ha armi, ma si combatte con le idee: quelle della sussidiarietà . E si sa che la Costituzione, nei suoi cambiamenti del 21, alla voce Titolo V, prevedeva di quel principio un applicazione vera, larga, compiuta, nel solco di una considerazione semplice: lo Stato non può o non riesce ad intervenire, in un settore? Il monopolio privato, o la liberalizzazione non sono le uniche soluzione. La via può essere quella del comune: protagonisti i cittadini. E in questa espressione di “cittadinanza”, non c’è soltanto una carta di identità , un aggiornamento del vocabolario rispetto alla parola di “amministrato”. C’è qualcosa di più.
Sussidiarietà e partecipazione: la Costituzione che si rinnova
C’è la partecipazione civile che incalza, e reclama spazi nuovi. Con tanti soggetti diversi, oggi più che mai: associazioni, fondazioni, cooperative sociali. Oltre i partiti, o i sindacati. C’è poi uno spazio pubblico dalle tante forme, più articolato, policentrico, e dove le forme di social networking sono sempre più determinanti nella creazione di comunità , relazioni, anche modelli di nuove istituzioni. Si respira insomma la necessità di una cultura diffusa della cittadinanza, e di un’idea per cui la partecipazione del nuovo millennio non sia solo voto, contributo fiscale, elettorale, ma anche iniziativa autonoma se necessario.
Nel frattempo i diritti e i beni da tutelare aumentano, con nuovi soggetti che entrano nel gioco collettivo, e la conoscenza del diritto che cambia, e magari prova a semplificarsi, è indispensabile per sapersi muovere sulla scacchiera.
Un’iniziativa molto utile, per provarci, può essere ripartire dalla Costituzione: riscoprire quella forza che l’ha resa modello per tante realtà , europee e non. E vedere la sua generalità non come sinonimo di vaghezza, di tutto fumo e niente arrosto, ma semmai la lungimiranza di chi sapeva vedere lontano, e immaginava che se i principi non devono cambiare, le forme e gli strumenti per comunicarli possono e devono cambiare.
Cittadinanza e Costituzione: un momento di studio
Ma in che direzione? Una proposta la troviamo nel Master ” CITTADINANZA E COSTITUZIONE ” , organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. In collaborazione con il Centro Studi per l’Educazione alla Legalità , il Centro di Ricerca sulle Relazioni Interculturali, il Centro di Ricerca sull’ Educazione ai Media, all’ Informazione e alla Tecnologia (CREMIT) e con il patrocinio del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa, l’occasione di studio è ghiotta. Durata un anno, fino al marzo 214; week-end intensivi su sei moduli tematici; borse di studio erogate da Enti Promotori – fra cui ANCI e la Regione Lombardia – e una convenzione con Banca Intesa Sanpaolo per la concessione di prestiti d’onore finalizzati alla copertura delle tasse universitarie, il corso punta ad offrire una formazione teorica e pratica, e che soprattutto risponda a tre criteri: aggiornata, interdisciplinare, consapevole. Sul concetto di cittadinanza oggi.
Sul primo punto l’obiettivo è capire i fenomeni emergenti: cosa vuol dire mettere in moto e in rete le realtà locali, legarle nella loro autonomia, ma senza tradire lo spirito di cooperazione che unisce luoghi di decisione più grandi: gli Stati, nei grandi organismi internazionali. Oppure sapere cosa sia la società della conoscenza, e fare della cultura e della formazione una variabile vincente per migliorare i sistemi economici mondiali, e coordinarli.
Spostiamoci quindi al secondo profilo. E per metterla semplice, bisogna mescolare i campi, le discipline. Storia, antropologia e diritto. E poi economia, scienza politica, sociologia e pedagogia, bioetica e cinema: tutto può essere scuola di cittadinanza. Essere cittadino vuol dire anche essere inserito nel proprio tempo, che è fatto di un certo assetto politico e giuridico, per sentirne le crepe quando esistono . Essere cittadino vuol dire spaziare da parole come Chiesa, Impero, nazione, polis e civitas, fino a concetti come welfare, multimedialità , educazione civica. Essere cittadino in Italia, vuol dire sapere come nasce la nostra Costituzione, quali organi istituzionali prevede, e il modo con cui questi organi, dal Governo al Parlamento, devono rapportarsi ad agenti istituzionali più o meno vogliosi di cambiamento: dagli Enti locali a quelli dell’Unione Europea, tra autorità politica, partecipazione all’autorità , e la via del decentramento come risorsa. Tutto questo, nel cuore del secondo modulo, vedrà protagonista proprio il principio di sussidiarietà .
Veniamo quindi, di necessità , al terzo aspetto. La sussidiarietà ce lo permette, visto che accettarla come stella polare è già di per sè un mettersi al passo con i problemi di oggi. Ecco allora che essere aggiornati porta ad essere non solo figli, ma anche interpreti del proprio tempo. Facendo propri il problema della legalità , e dell’educazione alla legalità : quali i soggetti, le pratiche giuste? Famiglia, scuola, o c’è altro? Spazio quindi ai modelli che aprono al cittadino come soggetto che può decidere senza filtri, o di farlo confrontandosi con le opportunità e i rischi dei media digitali. Con la giusta conoscenza del fenomeno, e la responsabilità di assicurare un rapporto equilibrato fra pubblico e privato.
Questi quindi, sono gli input e le premesse. Completata la fase di iscrizione a metà febbraio, speriamo che quest’occasione di studio, coordinata dal Prof. Robertino Ghirighelli, già Direttore dell’Istituto di Storia moderna e contemporanea e Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche nella facoltà di Scienze della Formazione dell’Università , sforni cittadini nuovi e forti. Perchè consapevoli.