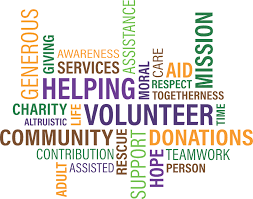Il parere
Il Comune di Nole (To), avendo istituito un servizio bibliotecario comunale che, a mente del relativo regolamento successivamente approvato, deve essere svolto da personale volontario, non retribuito, sotto il coordinamento di un dipendente comunale appositamente individuato, chiede al Giudice contabile se è legittimo il ricorso a forme di volontariato a titolo individuale con assicurazione a carico del comune. L’oggetto del parere è duplice: logicamente preliminare è la richiesta circa la possibilità per l’ente pubblico di giovarsi di servizi prestati da personale volontario al di fuori delle apposite convenzioni di cui all’art. 7 l. 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato); in via subordinata, si chiede di conoscere quale sia il soggetto su cui grava la copertura assicurativa di coloro che svolgono attività di volontariato a titolo individuale in favore di pubbliche amministrazioni.
Il collegio conferma i prevalenti orientamenti riguardanti gli artt. 4 e 7 l. n. 266/1991 (il cui contenuto è ora recato dagli artt. 18 e 56 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, codice del terzo settore). Le organizzazioni del terzo settore devono coprire da taluni rischi i propri aderenti che prestano attività di volontariato, stipulando apposite polizze assicurative (art. 4). Per converso, in capo alle pubbliche amministrazioni grava esclusivamente l’obbligo di farsi carico degli oneri derivanti dall’assicurazione (art. 7), obbligo che scatta solo al momento della conclusione di una convenzione ex art. 7 l. n. 266/1991. Ne discende, conclude il parere, una distinzione tra il soggetto tenuto a stipulare il contratto di assicurazione, sempre e solo l’organizzazione di volontariato, ed il soggetto sul quale grava il peso economico della copertura che, nel caso di convenzione, è l’ente pubblico.
Tuttavia, cosìargomentando, i magistrati piemontesi affermano che è comunque «consentito all’ente locale di avvalersi di lavoro prestato a titolo individuale gratuitamente in regime di volontariato », smentendo un recente arresto della giurisprudenza contabile, reso anch’esso in sede di controllo, riguardante un caso del tutto analogo a quello che ci occupa (C. Conti Toscana, Sez. contr., Delib. 30 settembre 2016, n. 141). In quell’occasione, era stata radicalmente esclusa la legittimità del ricorso a forme di volontariato a titolo individuale, al di fuori, cioè, di un regolamento convenzionale intercorrente tra organizzazione e pubblica amministrazione.
La convenzione, allora, secondo il parere in commento, non sembra più essere condizione di legittimità per lo svolgimento di servizi in regime di volontariato, ma mero requisito affinché sia l’ente territoriale a farsi carico del peso economico relativo alla copertura assicurativa dei volontari.
Il commento
La vicenda in commento offre l’occasione per precisare il regime cui soggiacciono i patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. In altri termini, ci si domanda se la legge quadro sul volontariato (e adesso il codice del terzo settore) sia idonea a regolare i rapporti tra amministrazione e amministrati allorché patti di tal fatta siano posti in essere e, per ciò che più in questa sede interessa, se i cittadini attivi debbano essere inquadrati come volontari ai sensi della normativa statale, con le rilevate conseguenze in materia di oneri assicurativi.
A ben vedere, in disparte le evidenti analogie, sussistono alcune differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni ex art. 7 l. n. 266/1991 (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrapponibili le rispettive discipline.
I patti sottendono un modello di amministrazione, non riprodotto dalla legge quadro, in cui le scelte sono condivise con gli amministrati. Tuttavia, da ultimo, il nuovo codice ha tentato di colmare tale lacuna, predisponendo forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore, estrinsecantisi in strumenti di co-programmazione e co-progettazione (art. 55, co. 2 e 3).
Ulteriori, e, forse, maggiori, differenze si appuntano sull’oggetto di tali strumenti negoziali. I patti riguardano singoli beni comuni urbani, che i cittadini si occupano di curare o di rigenerare: i cittadini non si ” sostituiscono ” all’amministrazione, ma vi si ” affiancano ” . Mediante le convenzioni, invece, l’ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale » (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale). E’ evidente, dalla lettura del dato positivo, come il legislatore statale si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti coinvolti e, dall’altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l’utilizzazione del personale » (C. Conti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità , iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull’amministrazione condivisa, oltre che dall’art. 118, quarto comma, Cost.
Le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017. Ad esso, infatti, si affiancano i regolamenti comunali. Essi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà , da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un’interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l’interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto.
Leggi anche:
La prima assicurazione in Italia dedicata ai cittadini attivi per i beni comuni
I cittadini attivi si possono assicurare perché non rientrano nel volontariato di cui alla legge n. 266/1991
Il Terzo Settore trova il suo ancoraggio nella sussidiarietà e nell’interesse generale
ALLEGATI (1):