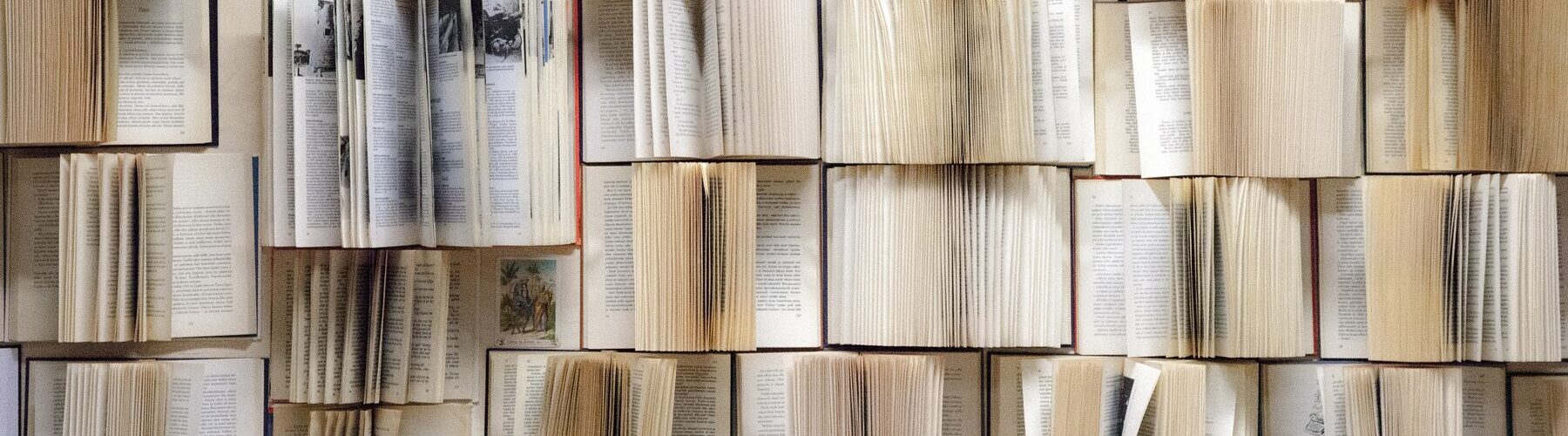Le innovazioni che le energie migliori di questo Paese propongono, le proposte sagge per adeguare il nostro Paese al passo dei tempi, si scontrano in Italia con il vero potere assoluto della Burocrazia: il Moloch che costringe ad infrangersi contro il muro dei “non è possibile”, “non si può fare” (o “si può fare solo così”, che per certi versi è peggio delle precedenti risposte). E, alla fine, alla sconfitta di ogni speranza di cambiamento.
Il Moloch della Burocrazia, contro ogni cambiamento
È la tesi che sostiene Marianella Sclavi, maestra dei processi partecipativi e democratici, in un articolo sul sito di Sbilanciamoci.info, dal titolo esplicativo: Al di là del muro della burocrazia. L’autrice lo fa recensendo due libri: il primo è Coltivare Partecipazione, una preziosa raccolta di esperienze e processi partecipativi raccontati dall’Associazione AIP2 (Associazione italiana per la partecipazione pubblica). Il secondo è I custodi della bellezza di Gregorio Arena, a cui Sclavi dà il merito (con la sua “invenzione” del Regolamento di amministrazione condivisa dei Beni comuni e l’associazione Labsus nata per promuoverlo e sostenerlo) di essere riuscito a mettere in moto un processo che chiama di “sbaraccamento della burocrazia”, che «nessun parlamento finora ha mai neppure provato a mettere a fuoco, e che si è espanso quasi in sordina, senza farsi troppo notare, arrivando a coinvolgere delibere dei consigli comunali di più di 200 città».
La Scalvi riconosce che «non è facile aiutare la opinione pubblica ad appassionarsi a queste nuove prospettive», il tema della burocrazia, con la quale purtroppo i cittadini hanno a che fare tutti i giorni, crea l’orticaria solo a citarla. Per questo farlo in un’ottica innovativa richiede una doppia visione: «le nuove ottiche se prese sul serio», afferma l’Autrice, «permettono di prendere le distanze dalle gabbie mentali che ci tengono prigionieri. Le principali gabbie, o miti, che grazie a queste esperienze possiamo evidenziare sono le seguenti: A. la semplificazione (opposta al complesso); B. la priorità dei regolamenti (opposta alla priorità dei principi e dei valori); C. l’astratto e il generale (opposto al concreto e unico); D. il ragionamento dialettico come viatico per le soluzioni (opposto al dialogico aperto alla esplorazione dei mondi possibili». E le spiega in maniera precisa e chiara con due esempli eclatanti riferiti a due importanti esperienze di due comuni (Camaiore e Buonconvento), dove la democrazia partecipata (o deliberativa) non solo ha funzionato come dinamica efficiente per la presa di decisioni positive e condivise, ma alla fine anche per ricostituire un tessuto di convivenza civile (risorsa preziosa e scarsa) basato su fiducia e ascolto reciproco.
La fiducia: la grande assente di questi tempi
«Ma come si fa a conquistare la fiducia di abitanti che proprio perché sensibili e attenti ai problemi della manutenzione del territorio, sono totalmente sfiduciati?», si chiede Sclavi. «Bisogna ascoltare la loro personale esperienza, le loro osservazioni e proposte con estremo rispetto e considerazione. Bisogna comunicare loro che nel progetto in atto, si partirà dall’insieme delle osservazioni ed esperienze concrete, circostanziate, e si lavorerà col metodo delle proposte positive, imparando da tutte le buone pratiche esistenti, per elaborare delle soluzioni e progetti di mutuo gradimento. Al posto della selva oscura dei “regolamenti”, i cittadini attivi guardano da un lato al loro territorio e dall’altro direttamente ai valori e principi della Costituzione e in particolare quell’art. 118 (Nuovo Titolo V, ultimo comma, 2001) che ha introdotto il diritto dei cittadini a occuparsi del bene comune».
Ecco il valore aggiunto che questo sistema genera e diffonde. Altro che lentezza, conflittualità perenni e decisioni “di pancia” o contrapposizioni nefaste. «La verità è esattamente il contrario», afferma con ostinazione una delle fautrici più longeve e accreditate di questo sistema. È proprio «nella misura in cui le persone sono costrette a rapportarsi le une alle altre come una sommatoria di ego isolati, come succede nelle nostre assemblee e riunioni politiche, e nei rapporti fra cittadini e uffici della PA, che i cittadini quando si incontrano sono sospettosi e litigiosi e la dinamica di gruppo viene dominata dalla necessità di difendersi e schierarsi. È nella assenza della capacità di iniziative positive comunitarie, che i boss delle varie cosche possono intimidire e comandare ed è grazie alla difesa dei “segreti di ufficio”, che gli speculatori possono far valere il governo delle tangenti». E invece la democrazia deliberativa va in tutt’altra direzione: «consiste nel costruire delle forme di rappresentanza politica ad hoc, diverse sia dalla democrazia rappresentativa parlamentare classica che dai referendum e a loro complementari. È una rappresentanza che non ha come scopo mettere una ideologia od opinione contro l’altra, ma far emergere dalla diversità l’intelligenza collettiva, con un mandato di equità sociale».
Proseguendo, la Sclavi alza il tiro: «l’accaparramento da parte dei poteri forti dei compiti di progettazione del territorio non solo oggigiorno è la premessa per dei grandi disastri materiali, ma anche spirituali in quanto nega alle persone il diritto a una convivenza arricchita da immaginazione e intelligenza collettiva».
I tre aspetti “geniali” del Regolamento
Eppure, l’Italia è un Paese – contrariamente agli stereotipi – molto amato dalla stragrande maggioranza dei suoi abitanti. Per questo individua tre aspetti che le paiono “geniali”, alla base del Regolamento. «Il primo è la decisione di attuare un principio costituzionale non attraverso una legge, ma direttamente attraverso un regolamento comunale. Una mossa in sintonia con un ampio movimento presente in molti paesi del mondo, denominato “Localismo Costituzionale” per indicare un nuovo ethos civico e forma di governance che sposta il più grande numero possibile di decisioni pubbliche a livello di comunità, ancorandole direttamente al quadro di libertà e dei diritti garantiti dalla costituzione». Il secondo è «la istituzione di “atti amministrativi di natura non autoritativa”, detti “patti di collaborazione” che diventano il terreno giuridico che autorizza ed impone un rapporto dialogico e di co-progettazione fra cittadini e operatori e dirigenti della PA»; infine, il terzo aspetto è che «cittadini e amministratori, impegnati nel redigere quel Patto di collaborazione che si attaglia alle loro esigenze, stanno dando vita a un nuovo modello di azione dei pubblici poteri, ispirato a una logica di apertura, interazione, confronto con la società civile nell’ottica di un rovesciamento che vede la regola giuridica originarsi non più soltanto dall’alto ma anche direttamente dal basso: verso una orizzontalità e modalità di produzione normativa di tipo reticolare».
E se democrazia deliberativa e Patti di collaborazione si integrassero?
E finisce lanciando una sorta di appello, una nuovo percorso di collaborazione e di reciproco arricchimento, secondo lei decisivo per l’affermazione della democrazia partecipata: «un dialogo fra change agents, fra persone impegnate nei due campi, quello della democrazia deliberativa e quello dei Patti di collaborazione, in cui i primi si facciano carico della questione giuridica e i secondi delle competenze in dinamiche di gruppo e ascolto attivo e l’utilità del ricorso alle competenze dei facilitatori».
Conclude con una domanda: la questione da porsi, e che questi due libri aiutano a porci è: «Come mai nessun partito politico, neppure quelli di sinistra che in qualche modo avrebbero come obiettivo l’ampliamento della democrazia e della giustizia ed equità sociale, hanno mai messo seriamente in discussione un assetto burocratico autoritario, di stampo patriarcale, che obbliga i cittadini a stare zitti e buoni in sala di attesa fra una tornata elettorale e l’altra?».
Foto di copertina: Kerttu su Pixabay