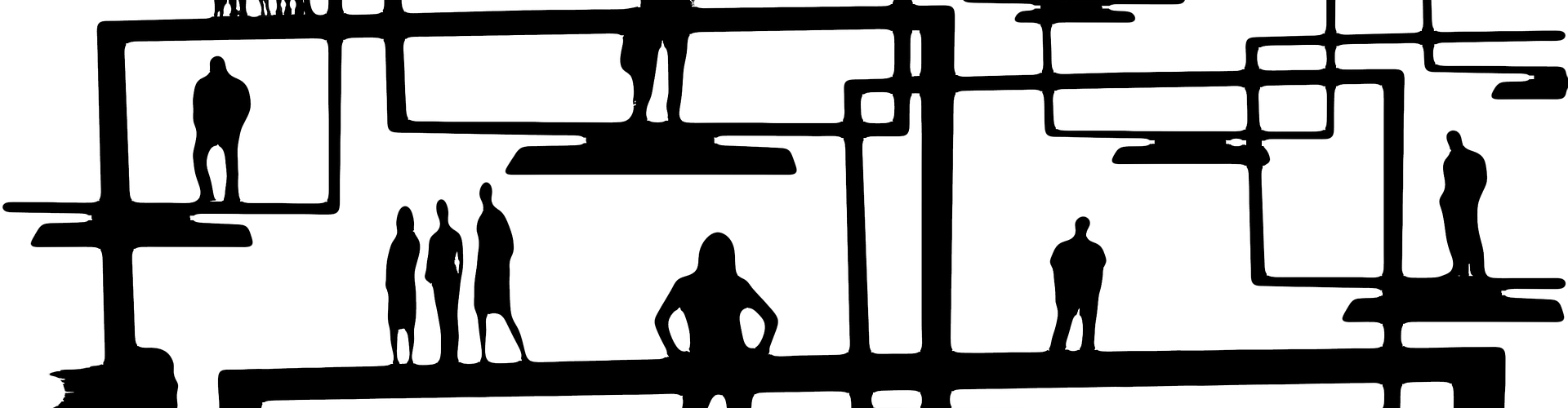Per i temi studiati da Labsus, la sentenza del 24 gennaio 2020, n. 958, del Tar Lazio-Roma, sez. III-bis, rappresenta una conferma in merito alla qualificazione pubblicistica dei Fondi Paritetici. La tesi pubblicistica, del resto, era già stata oggetto di giudizio e supportata nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4304 e nel giudizio del Tar Lazio-Roma, sez. III-bis, 31 gennaio 2017, n. 1590. Oltre a ciò, nel testo della sentenza viene esplicitamente richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale. Tale richiamo, tuttavia, per quanto rappresenti un elemento positivo nell’orizzonte della diffusione della cultura della sussidiarietà, risulta criticabile.
I Fondi Paritetici e l’Anpal
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali. Si basano su Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Decreto Legislativo n.150/2015 riconosce l’importanza e il valore di tali organismi, inserendoli all’interno della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito d’indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai Fondi interprofessionali, anche su proposta dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), alla quale è affidata la gestione dell’Albo nazionale degli enti di formazione accreditati sulla base delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome, nonché la definizione e realizzazione, in cooperazione con tutti gli enti ed istituzioni interessati, di un sistema informativo della formazione professionale, ove saranno registrati i percorsi formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. L’Agenzia svolge anche un’attività di vigilanza sulle attività svolte dai fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il commento
La sentenza del 24 gennaio 2020, n. 958, del Tar Lazio-Roma, sez. III-bis, vede come protagonista il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale Per la Formazione Continua nel Terziario, che ha avanzato la richiesta di annullare la nota dell’ANPAL, del 06.06.2017 prot.0007837, sugli esiti relativi ai controlli effettuati sull’attività formativa del Fondo per le annualità 2009-2010-2011.
Nella sentenza in oggetto si ribadisce che, senza ombra di dubbio, la base della natura dei Fondi è di tipo privatistico, in quanto contrattuale. Tale natura, però, non comporta un’automatica esclusione della qualificazione dei Fondi in termini di organismi di diritto pubblico, in virtù della natura degli interessi di cui si prendono cura. Si avvantaggia, dunque, una prospettiva oggettiva rispetto alla natura meramente soggettiva dei Fondi. Per il giudice amministrativo, infatti, risulta rilevante focalizzarsi sull’attività svolta. Un organismo finalizzato alla promozione del diritto al lavoro, alla formazione e all’elevazione personale e imprenditoriale persegue infatti interessi connessi al compito previsto per la Repubblica dagli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. A supporto di questa tesi, la sezione III-bis del Tar Lazio evidenzia che la previsione di una sanzione in capo al datore di lavoro che ometta il versamento al Fondo rappresenta una conferma della natura pubblicistica dei contributi che riservati ai fondi. Trattandosi di prestazione imposta finalizzata al perseguimento di un interesse generale, costituzionalmente tutelato, si deduce che le relative risorse cessano di essere puramente private.
Una qualificazione criticabile
Guardando al dato letterale della sentenza, però, è evidenziabile una percezione criticabile da parte della Sezione che ipotizza, per il caso preso in esame, una «delegazione di funzioni pubbliche» secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, ex art.118, ultimo comma, della Costituzione. Tale affermazione appare in contrasto con la natura del principio di sussidiarietà orizzontale, in virtù del quale ogni cittadino, singolo o associato, si può attivare per la cura di Beni comuni, in un’ottica di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni. Nell’ipotesi di “delegazione di funzioni pubbliche”, così come definita nel testo della sentenza, sembra venire meno il cuore del principio di sussidiarietà, rinvenibile nella sua natura collaborativa. Questa natura collaborativa, che potrebbe essere comparata a un rapporto dialogico da cui fare emergere nuove risorse, opportunità e forme di collaborazione, non risulta inclusa in ipotesi di mera delegazione di funzioni. Riconducendo la fattispecie alla delegazione, piuttosto, si potrebbe delineare un caso di esternalizzazione.
A supporto di questa tesi, si vuole richiamare all’attenzione il testo del quarto comma dell’articolo 118 delle Costituzione, il quale prevede che «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»; non si può, del resto, dimenticare l’importanza dell’utilizzo del verbo “favoriscono”. Nonostante siano prospettabili varie sfumature di questa scelta linguistica, ritengo sia opportuno in questa sede metterne in luce la portata “omissiva”. Come evidenziato in dottrina, infatti, tale scelta rappresenta un impedimento per l’amministrazione pubblica di trasformare in enti (formalmente o sostanzialmente) pubblici i soggetti giuridici originatisi in seno all’autonomia privata, allorquando le attività che essi svolgono assumano la rilevanza di interesse pubblico. Alla luce di tale limite, dunque, così come risulta inaccettabile il procedimento di pubblicizzazione dei soggetti che conducano attività di interesse pubblico, originati dall’autonomia privata, appare parimenti inaccettabile ipotizzare che, appurata la natura pubblica dei Fondi in ordine al tipo di attività che pongono in essere, basti tale natura per supportare la tesi della sussidiarietà orizzontale. Proprio alla luce del riconoscimento della natura pubblica dei Fondi si potrebbe, piuttosto, considerare come limite ai fini dell’inserimento nella categoria iniziative di collaborazione “dal basso” basate sull’art.118, quarto comma. In conclusione, dunque, per quanto possa suscitare interesse e risulti positivo vedere richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale, cuore dell’attività pluriennale di Labsus, emerge la necessità di evitare confusione e false attribuzioni. Là dove si ipotizza un caso di delegazione di funzioni pubbliche non è applicabile il paradigma della sussidiarietà orizzontale.
Foto di copertina: Gerd Altmann da Pixabay
ALLEGATI (1):