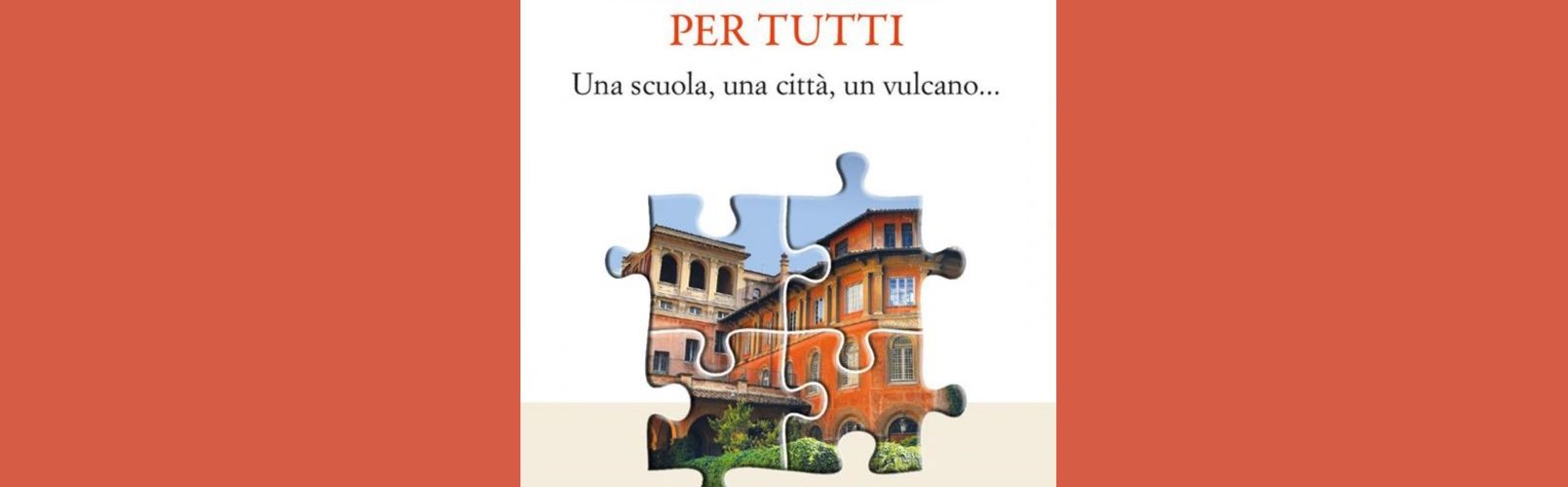Per la sezione Ricerche, pubblichiamo la recensione dell’opera “I beni comuni per tutti” di Gianfrancesco Fidone ed edita da ETS (2021).
Il libro
In Italia il dibattito sui beni comuni è stato molto acceso e animato in questi anni e si è sviluppato in sedi accademiche e non. Tuttavia, anche quando il luogo del confronto non è stato quello riservato ai soli esperti, il livello di discussione non ha mai smesso di essere particolarmente difficile per chi è a digiuno di nozioni scientifiche e di quelle giuridiche in particolare. Per questo il libro di Fidone, giurista e avvocato romano, è particolarmente apprezzabile: già nel titolo manifesta l’intenzione di rivolgersi a tutti, traducendo in modo semplice (la semplicità di Calvino da non confondere con la banalizzazione) concetti che presentano un elevato grado di complessità. La sensazione è che il risultato atteso sia stato raggiunto perché il libro non vuole essere un saggio semplice, ma è innanzitutto una riflessione fatta in prima persona con diversi e ricorrenti richiami a vicende autobiografiche che rendono la lettura agevole.
Fidone, infatti, non fa lo sforzo di rendere accessibili valutazioni che aveva già svolto in una precedente monografia scientifica, semplicemente perché lui è stato parte attiva di più comunità che si sono interessate dei beni comuni a Roma. La speculazione teorica si confonde con l’esperienza diretta e le valutazioni svolte nel libro partono sempre da domande molto concrete che gli interlocutori, che lui ha incontrato in questi anni, hanno avanzato senza porsi tanti problemi sulle implicazioni teoriche. La base teorica solida delle conoscenze dell’autore ha però consentito di orientarsi in modo quanto più sicuro nell’affrontare i concreti problemi. Per questo a essere per tutti non sono solo i beni comuni, ma lo è il libro in sé.
La definizione
Si tratta di un merito importante che si misura già con la nozione dei beni comuni, che forse è il punto in cui gli orientamenti registrati in questi anni hanno maggiormente dimostrato i loro limiti, perché Fidone offre un’interpretazione tanto pragmatica quanto solida riconoscendo come tali quelli in cui si sviluppa una relazione di interessi omogenei tra una comunità di soggetti e alcuni beni, a prescindere di chi sia il proprietario. Queste relazioni di interesse assumono per alcune condizioni, che non sono né assolute né costanti, una rilevanza giuridica al punto che la cura e l’uso di quel bene non dipendono più solo dai proprietari ma anche dalla comunità di riferimento. Nel libro, appunto, si esemplifica dicendo che sono una comunità i residenti di un’area circoscritta rispetto all’uso di una piazza che è inclusa lì, i genitori rispetto alla scuola frequentata dai propri figli e al suo uso, l’organizzazione più o meno formale costituita intorno a un bene di valenza storico e culturale di cui si vuole promuovere la conoscenza ecc. La relazione tra una comunità e un bene rende quest’ultimo di interesse comune, diverso tanto dall’interesse pubblico, quanto dall’interesse privato.
È da questa condizione che è possibile enucleare una serie di diritti che la comunità può vantare su questi beni, la cui legittimazione può essere fatta derivare da un titolo che – anch’esso concreto – può essere di volta in volta diverso: legislativo, amministrativo, per consuetudine o anche di ordine giurisprudenziale. Questa conclusione rende immediatamente chiaro e concreto il concetto di bene comune e fa capire come questi si riconoscono solo a partire da alcune condizioni specifiche e sono diversi dai commons e dai new commons.
La relazione tra diritti e doveri
La condizione giuridica di diritto delle comunità non è mai separata da quella dei doveri, che si realizza nella gestione: c’è un’inestricabile connessione tra diritti e doveri quando si parla dei beni comuni. Infatti, il riconoscimento dei diritti presuppone non solo l’esistenza di un bene e di una comunità di riferimento: è solo l’attivazione concreta della comunità per la loro tutela che permette di riconoscere anche dei diritti. Per sviluppare questa connessione, però, l’attivazione della tutela non deve dimostrarsi solo strumentale, ma finalizzata a un’effettiva cura del bene che si è manifestata concretamente. Correttamente l’autore iscrive questa nesso nel principio di sussidiarietà orizzontale e cita in particolare modo i Patti di collaborazione: il sostegno dell’ordinamento è dovuto laddove i cittadini si attivano per lo svolgimento degli interessi generali. È lo spontaneo e volontario attivismo in adempimento di doveri di solidarietà che consolida i diritti; questi ultimi non sono in sé, come lo sarebbero i diritti reali, i diritti personalissimi o, anche, i diritti sociali. Non è un caso che il primo capitolo del libro, dedicato all’individuazione dei beni comuni e alle utilità che essi producono per le comunità, si intitola “Difendiamo i beni comuni“: la rivendicazione di diritti parte innanzitutto dall’esercizio di doveri.
In questo senso la rievocazione che Fidone fa della contrapposizione tra Rodotà e Violante meriterebbe forse un aggiornamento. Quello a cui abbiamo assistito proprio con l’emersione dei beni comuni non è la consueta contrapposizione dei diritti ai doveri o la necessità che ai diritti si accompagnino i doveri; risulta, invece, interessante notare come l’esercizio dei doveri genera diritti. È un aggiornamento fecondo di quella classica dialettica che proprio i beni comuni hanno saputo evidenziare.
Tra le numerose implicazioni che l’autore sottolinea a proposito dei beni comuni, quattro meritano particolare attenzione.
Le forme organizzative
La prima concerne la veste formale che deve assumere la comunità quando intende gestire i beni comuni. Sebbene il libro ribadisca molte volte la necessità di non confondere i cittadini delle comunità con i volontari, l’autore sottolinea la necessità che questi assumano una struttura organizzativa riconoscibile sotto forma di ente non profit. L’espressione è utilizzata in senso a-tecnico, ma allude alle forme organizzative che oggi sono riconosciute come enti del Terzo settore. È indubbiamente vero che quando l’azione di difesa dei beni comuni si sostanzia in forme di gestione l’interlocutore deve essere riconoscibile e oggetto di imputazione giuridica soggettiva; ciò richiede una strutturazione organizzativa. Tuttavia, proprio i Regolamenti comunali dei beni comuni, che Fidone riconosce essere la forma più avanzata di cura dei beni comuni che si è diffusa in Italia, danno spazio a soluzioni più ampie ed eterogenee, riconoscendo la possibilità di interlocuzione anche a singoli o a gruppi non strutturati in associazione. Ad esempio, in un’importante pronuncia la Corte dei conti, vincendo una tradizionale ostilità a riconoscere il sostegno dei comuni nella stipula di polizze assicurative per singoli volontari, ha ammesso che ci possono essere altre forme di interlocuzione, che non necessariamente richiedono la costituzione di persone giuridiche. D’altra parte, distinguere i cittadini attivi dai volontari e poi richiedere loro di strutturarsi come le organizzazioni di volontariato appare una contraddizione, che produce un rischio: assoggettare le esperienza di cura dei beni comuni all’applicazione della disciplina del Terzo settore, da cui invece la prima mantiene tratti di differenziazione.
Il rapporto con il mercato
L’altro tema di grande interesse che l’autore affronta è il rapporto con le esigenze economiche delle comunità. L’approccio che usa l’autore pare corretto: anche su questo tema bisogna avere un atteggiamento pragmatico che non ne rifiuti aprioristicamente l’associazione. Da questa posizione iniziale discendono conseguenze condivisibili. Non si può, infatti, trascurare che la difesa dei beni comuni abbia dei costi, che sono anche di natura economica. Rispetto a questi, se pare corretto sostenere che del loro sostegno si deve fare carico la comunità e quindi non sarebbe appropriato un’attivazione con garanzia totale della copertura dei costi, non appare neppure ragionevole impedire che la comunità si attivi per generare ricavi o per beneficiare di servizi agevolati. Ne discende che appaiono compatibili con queste esperienze sia le forme di contribuzione volontaria, sia i ricavi da attività economiche accessorie sia il coinvolgimento vero e proprio di professionisti o imprese private che svolgano l’attività a titolo gratuito o con ritorni indiretti. La condizione essenziale, che anche Fidone considera fondamentale, è che questi ricavi e vantaggi non siano goduti da singoli individui della comunità, ma siano al servizio della realizzazione dei progetti legati ai beni comuni. In questi termini, quella che l’autore definisce la gestione comune orientata al mercato pare condivisibile, perché in effetti nessuna di queste operazioni pare entrare in contraddizione con l’obiettivo principale che è quello di garantire l’uso comune del bene; semmai, come Fidone sostiene, si tratta di soluzioni che irrobustiscono l’azione delle comunità.
Proprio per questo, però, non sembrano essere dello stesso tenore soluzioni, che pure l’autore prospetta, che vanno nella direzione di regolare l’accesso ai beni con un prezzo sia se riservato ai non aderenti alla comunità sia se riservato ai componenti della stessa. In questo caso appare evidente che venga meno la condizione essenziale per riconoscere un bene comune: la non escludibilità. Si riproduce in questo senso una condizione di appropriazione che è estranea ai beni comuni. Si capisce che è possibile pensare che il buon uso dei beni possa dipendere anche da un gestione efficiente e con un prezzo di selezione, ma se si ricorre a questa soluzione la comunità non può più vantare dei privilegi che il principio di sussidiarietà orizzontale concede. La relazione è diversa e lo strumento di regolazione deve essere conseguente; tutto ciò somiglia di più a un contratto di concessione che deve seguire proprie e diverse regole. In altre parole, con queste soluzioni si produce una contraddizione che appare insanabile con i beni comuni.
Il governo delle autonomie civiche
Molto interessanti appaiono le considerazioni che l’autore svolge a proposito dell’Amministrazione condivisa, che è quel modello di governo della cosa di interesse pubblico diversa da quella tradizionale tipica delle pubbliche amministrazione e che coinvolge le comunità interessate ai beni comuni. Ancora una volta, partendo da esempi molto concreti che lo hanno riguardato, Fidone evidenzia che le comunità interessate ai beni comuni possono generare nuove forme di governo pubblico, in cui le pubbliche amministrazioni mutano il proprio ruolo in favore di organizzazioni che sono più flessibili, più capaci di acquisire informazioni e più in grado di intercettare i bisogni veri. L’autore vede l’Amministrazione condivisa non solamente come un modello alternativo a quello tradizionale, come anche ha riconosciuto la Corte costituzionale, ma una forma diversa di governo fondata su un’alleanza di autonomie di origine civica. Giustamente Fidone evidenzia che questo è risultato particolarmente vero durante la pandemia, dove i limiti dell’amministrazione tradizionale sono stati particolarmente evidenti. Intercettare i reali bisogni, calibrare le misure che ne assicurino la soddisfazione, garantire una risposta tempestiva sono esigenze che hanno mostrato tutta la potenzialità delle comunità autorganizzate di origine civica, dimostrando, peraltro, proprio come l’autore sottolinea, che i beni comuni sono moltiplicatori di interessi comuni.
Trasparenza e anticorruzione
Infine, totalmente condivisibili sono le osservazioni dell’autore in merito alla questione della trasparenza e del contrasto alla corruzione. La pretesa di risolvere questo problema con una soluzione meccanica e sempre valida, quale quella del ricorso al bando, appare nella sua assolutezza totalmente fallace, proprio perché – viceversa – gli studi dimostrano che quelle esigenze devono tener conto delle tipologie di relazioni che devono essere arbitrate. Non c’è dubbio che l’Amministrazione condivisa, nell’aspirazione di coinvolgere direttamente una comunità e quindi una pluralità di soggetti a debole strutturazione, è un forte propellente per la trasparenza perché implica di per sé l’apertura della gestione della cosa pubblica. Il coinvolgimento diretto dei cittadini è già di per sé un forte antidoto alla corruzione. Naturalmente si tratta di una trasparenza diversa da quella che abbiamo conosciuto in questi anni, che si fonda più sulla partecipazione che sull’ostensione degli atti, ma nondimeno appare coerente per quei fini.
D’altra parte condizioni opposte fondate su selezioni competitive significano automaticamente confutare il vantaggio che l’Amministrazione condivisa e il principio di sussidiarietà orizzontale vogliono concedere alle comunità interessate ai beni comuni. Pertanto, mentre l’Amministrazione condivisa non pare contraddire la trasparenza e le esigenze di anticorruzione, ma solo la pretesa che di esse esiste uno strumento univoco il bando selettivo, l’applicazione rigida e univoca di quelle disposizioni certamente implica la contraddizione rispetto al principio di sussidiarietà orizzontale e questo non sembra possibile. I principi, anche quando appaiono potenzialmente contrapposti, devono trovare una soluzione di coesistenza e non possono risolvere le loro antinomie con la prevalenza dell’uno sull’altro. L’Amministrazione condivisa, in questo senso, non si pone in contrasto con la trasparenza, ma delinea un diverso modo di garantirla, che deve essere rispettata.
D’altra parte, come Fidone dice alla fine, il successo delle esperienze di gestione dei beni comuni si fonda totalmente sulla fiducia ed è questa che permette di realizzare soluzioni adeguate ai problemi e produce quelle innovazioni sociali e istituzionali che appaiono sempre più evidenti nelle grandi trasformazioni che stiamo vivendo.